La testa tra le nuvole
di Melina Scalise – giornalista, psicologa
Ti è mai capitato di “avere la testa tra le nuvole”? Eppure, se ci pensi, non ci arriviamo nemmeno a toccarlo con un dito il cielo… per lo più lo desideriamo e, in quell’attimo, in quello sforzo che ci vede protesi verso l’azzurro infinito, ci vediamo il traguardo della nostra felicità. Invece no. Questo non succede quando ti immergi nel cielo, quando ci sei con la testa e invadi lo spazio del desiderio. Lì abbandoni il tendere verso la desiderata meta e vivi il momento della sperimentazione, della conoscenza e questo basta per scoprire che nel cielo azzurro esistono le nuvole.

Come sono candide le nuvole e nere e tempestose, immobili e velocissime, ombrose e minacciose. È lì che possiamo conoscere il caos, è lì che dimorano le saette degli dei. Noi, la testa tra le nuvole – tra quella confusione – preferiamo non mettercela se non per sognare. L’ebbrezza del caos ci attrae e disorienta, ci mette in pericolo e, ancor più, sappiamo quanto doloroso sia rimettere i piedi a terra. Lassù le nuvole ci danno le misure dello spazio. Lì abbiamo dato dimora al sacro e all’immaginario infinito, ma è a terra che si trova la nostra àncora e l’unica verità che ci appartiene. È insito nel corpo questo Vero, come ci ricorda San Tommaso che volle mettere il dito nella piaga di Cristo per credere nella sua Resurrezione. Noi la vediamo nella materia delle cose la certezza e all’esatto opposto c’è la volubilità delle nuvole. La verità esiste perché l’abbiamo conosciuta nel visibile e nell’ inevitabile fine della carne. Filosofi come Heidegger ci hanno anche insegnato quanto sia proprio tenendo presente la fine che possiamo permetterci i voli più alti senza temere di cadere. Sarà questa una buona ragione per non “cadere dalle nuvole”? Forse. Intanto mi domando se avete mai provato a starci sulle nuvole. Per davvero – intendo –per esempio volando. Pensateci… non è mai lassù che vogliamo guardare, ma quaggiù. In volo ci pervade il desiderio di guardare il mondo da un’altra prospettiva, di cercarlo e riconoscerlo: come uccelli migratori esploriamo il territorio in cerca della nostra casa. Sono proprio le nuvole, in fondo, con le loro inquietudini, che ci hanno spinto a mettere su casa. La parola casa deriva dal sanscrito ska e skad che significano coprire, luogo coperto, capanno, da cui deriva anche il termine cielo in inglese (sky) inteso come copertura nuvolosa (il cielo si identifica con le nuvole), mentre in latino la parola ombra, umbra, significa nuvola piena di acqua. Sempre dal sanscrito ska deriva la parola greca kasa e anche ska (pelle) e skia (ombra). Un giro di nomi per dirci che quasi come la pelle e la casa, le nuvole ci danno protezione e salvezza dal sole, ci portano l’acqua e aiutano persino a prevedere le loro stesse tempeste.

Quando le guardiamo scure addensarsi nel cielo o scorrere davanti al sole in spiaggia, filtrare i raggi solari al tramonto o basse, intrappolate tra le insenature delle colline, le nuvole giocano con uno dei nostri sensi più importanti: la vista. Sono loro che ci celano la luce e giocano con la vita. Ebbene è grazie alle nuvole che le donne da marito si chiamano nubili. La parola deriva dal latino nuptum, nubo (radice di nuvola), ovvero coprire, velare, perché era nell’uso romano coprire con un velo le spose per non mostrarle al futuro marito ed evitarne un rifiuto. Insomma, le mogli promesse dei matrimoni erano imprevedibili come le nuvole, come Pandora: pronte a seminare mali, fossero anche solo i piaceri carnali come predicava Sant’Agostino, ma, al tempo stesso, importanti per portare la vita. Resta che anche le nuvole portano sempre qualcosa, persino nei dipinti: basti osservare la Cappella Sistina di Michelangelo dove ogni nuvola è un territorio, uno spazio in cui il divino può apparire umano. Come ci ricorda il poeta serbo Dejan Stojanovic “Dio è una nuvola da cui è caduta la pioggia”.

Un limbo tra cielo e terra
di Ilaria Starnino – filologa
“Sì, è pazzia, senza dubbio, uscire dal mondo e, quasi che tutto il suo interno fosse già chiaramente conosciuto, frugare all’esterno: come se, poi, potesse tracciare la misura di qualcosa chi è ignaro del suo, o lo spirito dell’uomo sapesse scorgere ciò che nemmeno il mondo riesce a contenere” (Plin., Hist. Nat. I 1). Sarebbe bello sapere se Plinio il Vecchio, nel pensare la sua introduzione al primo libro della Naturalis Historia abbia anche solo per un minuto gettato il capo all’indietro e contemplato la volta celeste dalla quale lo separava, forse, una cortina di nubi, nate dall’incontro fra cielo e terra: “vi si mescola una quantità infinita di aria degli spazi più alti e una, pure infinita, di esalazioni terrestri, e ne risulta una fusione di queste due sostanze”, dice poco più avanti. Nella sua riflessione, il fenomeno naturale della formazione delle nubi diviene anche presagio di un cambiamento, che, se pur ha origine nel cielo, modifica le cose della terra.

Il passo che porta dalla scientificità del fenomeno alla sua lettura allegorica è davvero breve. Le aggregazioni di microparticelle di acqua o di ghiaccio, la cui superficie riflette la luce in tutte le direzioni, dando il caratteristico colore lattiginoso alle nubi, sono un limbo tra cielo e terra, un mondo alternativo alla realtà, nemesi della contemplazione, passeggera e spesso inconsistente. Lo sapeva bene il commediografo greco Aristofane, che alle nuvole aveva dedicato una sua commedia. Sono gli anni ‘20 del V secolo a. C., nel teatro di Dioniso le Nefélai, divinità del cielo, entrano in scena come coro, protagoniste e al contempo cornice di una metafora: la speculazione effimera e inconsistente di Socrate, attorno alla quale ruota tutta l’azione scenica, che fino alla fine riesce a conservare l’ambivalente interpretazione delle Nuvole. Il commediografo, infatti, alterna sapientemente l’elemento evocativo della speculazione filosofica alla concretezza degli effetti cosmologici che esse generano, mantenendo intatto il carattere della doppiezza delle divinità, tanto caro ai greci. La parodistica solennità del loro ingresso assume alti connotati lirici, e i ventiquattro coreuti intonano così il loro canto:
“Nuvole sempiterne, / noi visioni in lucente / figura di rugiada! / Dal padre Oceano che strepita cupo / leviamoci alle cime degli alti monti / chiomate di alberi, onde / contemplare le vette lontane / e le messi e la sacra terra irrigata / e il fragore dei fiumi divini / e il mare sonante dai profondi fremiti: / poiché l’occhio dell’etere splende instancabile / nello sfolgorio dei raggi. / Scuotiamo il nembo di pioggia / dal viso immortale, contempliamo / con occhio di lungo sguardo la terra” (vv. 275-290).
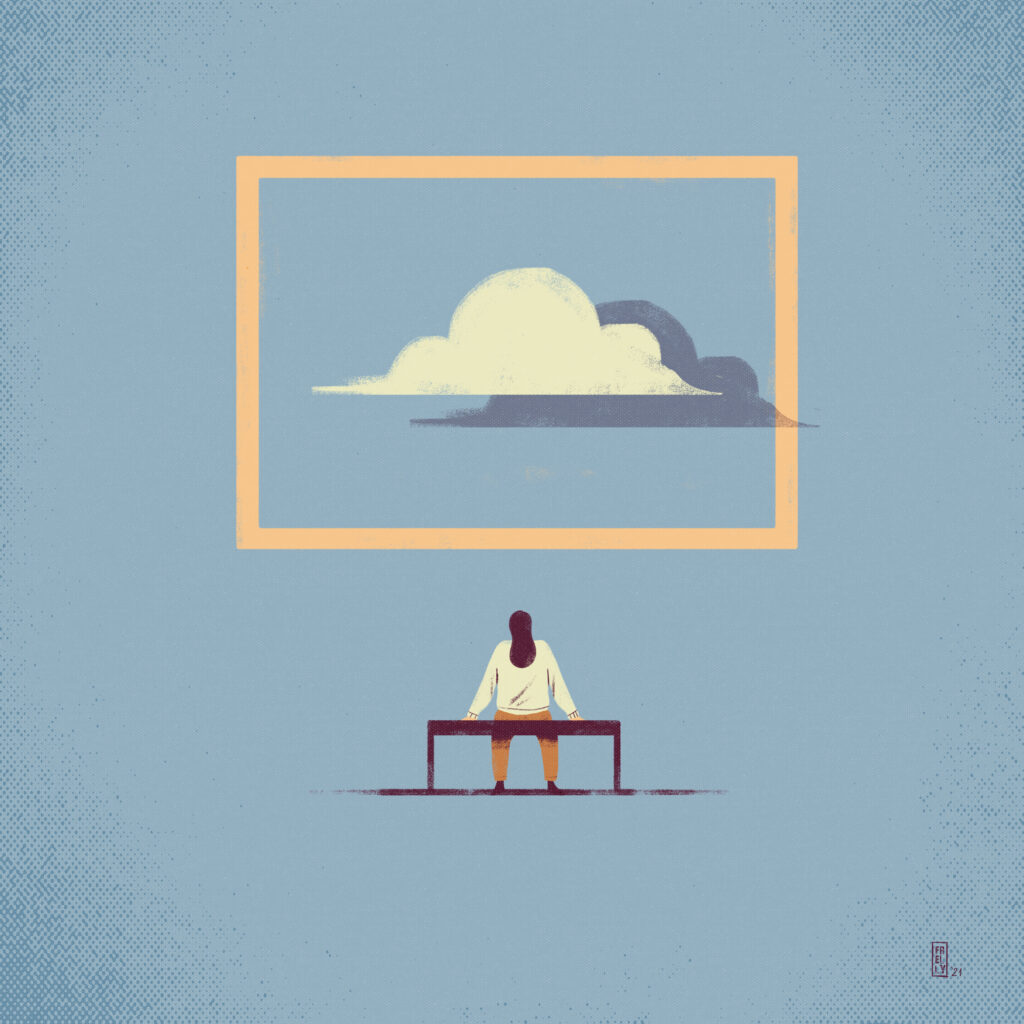
Quello delle nuvole è un mondo che sopravvive alla realtà, nel senso che vive sopra, in una perenne dialettica che registra la misura degli eventi umani sul ritmo universale della natura, a rendere meno immisurabile la distanza che ci separa della volta celeste, turbandola spesso nella sua serenità, facendo ritornare alla terra ciò che la terra ha sublimato. Sono quanto di più umano e terrestre il cielo possa accogliere, l’ultimo segno, quello fisicamente più alto, dell’imperfezione che ci caratterizza. Lo ricorda anche Dante, nel XXI canto del Purgatorio (vv. 43-54), quando il poeta affida a Stazio la spiegazione del perché nella parte più alta della montagna del Purgatorio l’aria non sia più soggetta ai perturbamenti terresti, lo spazio diventa più rarefatto ed obbedisce alle leggi divine:
Libero è qui da ogne alterazione: / di quel che ‘l ciel da sé in sé ricev / esser ci puote, e non d’altro, cagione. / Per che non pioggia, non grando, non neve, / non rugiada, non brina più sù cade / che la scaletta di tre gradi breve; / nuvole spesse non paion né rade, / né coruscar, né figlia di Taumante, / che di là cangia sovente contrade; / secco vapor non surge più avante / ch’al sommo d’i tre gradi ch’io parlai, / dov’ha ‘l vicario di Pietro le piante.

Sarà l’estrema volubilità delle nuvole, il loro incontenibile polimorfismo, l’instancabile intermittenza del loro esistere a generare negli uomini aspettative e illusioni: “allora, nel sogno, vedo le nuvole che si aprono e mostrano tesori pronti a cadere sopra di me – e quando mi risveglio, piango per sognare ancora”, dice Calibano nella sua struggente confessione dell’atto III de La tempesta di Shakespeare. La meteorologia, ricorda Daniele Del Giudice, è la scienza della previsione, ma anche della delusione. Domani le previsioni dicono nuvole sparse, pioggia in arrivo. Sarà una delusione vederla cadere dal cielo nel primo giorno di vacanze dalla scuola, sarà una benedizione sui solchi di terra arsi dal sole, nel mese di giugno che ha già dimenticato la primavera e sa ormai troppo d’estate.
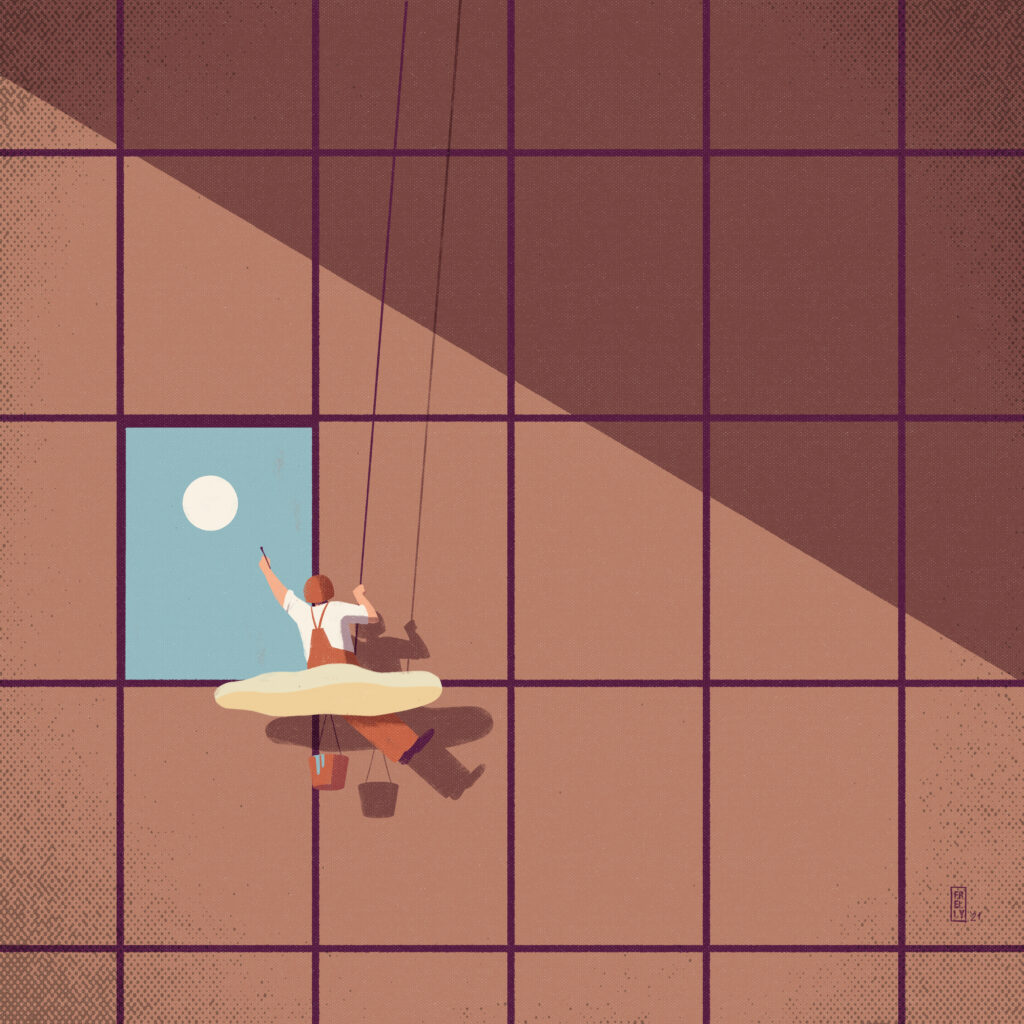
Illustrazioni di Enrico Focarelli Barone – Frelly



